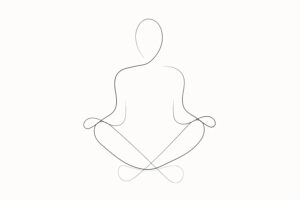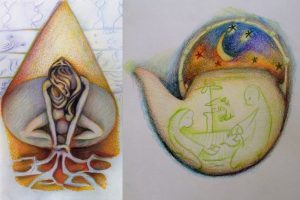Laura ha iniziato a praticare Haṭhayoga venticinque anni fa, io nel 1973, una vita fa. Nel rispondere alla domanda “Qual è la più grande lezione dello Yoga?” non abbiamo avuto dubbi: Lo Yoga ci ha insegnato il rispetto per il corpo.
Per lo Haṭhayoga il corpo umano è una rappresentazione dell’Universo, animata dalle stesse forze creative che hanno dato inizio alla manifestazione, e, in quanto tale, va considerato sacro, un tempio vivente da onorare e rispettare; si tratta di una verità auto-evidente che noi, però abbiamo fatto fatica a realizzare: negli anni della nostra adolescenza – almeno negli ambienti che frequentavamo – chi aveva cura del corpo veniva guardato quasi con sospetto. La mente, a ripensarci adesso, la faceva da padrona, ed era normale far uso di droghe e intossicanti vari per stimolarla ed aiutarla a superare quelli che venivano considerati limiti imposti dalla materia.
A quei tempi svegliarsi, magari in un letto sconosciuto, con la lingua impastata da alcol e hashish, rammentandosi poco o niente della notte precedente era considerato- secondo modelli e criteri tutt’ora condivisi dall’occidentale medio – “very cool”; un’avventura da raccontare in birreria o sulla spiaggia, davanti ai falò estivi, per suscitare risatine complici e borbottii di approvazione.
La mancanza di cura e, diremmo, di rispetto, nei confronti del corpo, non era una caratteristica precipua della nostra generazione, ma, a ben guardare una scelta culturale ed estetica perfettamente in linea con la mistica del sacrificio e con l’esaltazione della sofferenza come causa di salvezza eterna, tipiche della cultura cristiana e neoplatonica.
Con questi presupposti è facile comprendere come l’interesse, quasi eccessivo, che in quegli anni nutrivamo per l’India si focalizzasse soprattutto sulle pratiche di mortificazione del corpo, sul vegetarianismo estremo, sui digiuni e sull’uso rituale delle sostanze psicotrope; pratiche e “abitudini” che, in realtà rappresentano solo una piccola parte di quell’insieme tutt’altro che unitario, di tecniche e discipline che oggi chiamiamo Yoga.
Lo Haṭhayoga, ad esempio, come abbiamo scoperto studiando e praticando per decenni, passa dalla realizzazione della bellezza fisica, della forza, della salute e della longevità per giungere all’integrazione di “corpo, parola e mente” – o per meglio dire, “gesto, emozioni e pensiero” – intesi come modalità espressive, diverse, ma di eguale rilevanza, dell’essere umano.
La pari dignità attribuita al gesto, alla risata e alla più ardita speculazione filosofica, è stato per la nostra ricerca esistenziale uno snodo fondamentale, una chiave che ci ha portato, come dicevamo, alla riscoperta del corpo e alla sua “sacralizzazione”, con una conseguente, progressiva, trasformazione delle abitudini alimentari, del ritmo sonno-veglia e delle modalità di relazione sociale.
Una volta realizzato che il processo del pensiero e il processo, per esempio, della digestione rivestono nell’ambito della manifestazione, la stessa importanza, cambia completamente la visione del mondo e cambiano soprattutto, le priorità.
Per lo Haṭhayoga, il pensiero, la foglia o l’acqua che scorre, sono fatti della stessa sostanza: sono insiemi di particelle sottili, assemblati, in forme diverse dall’energia della natura, chiamata “Kuṇḍalinī” o “Śakti”. L’unica differenza tra l’essere umano, la nube o la foglia secca, è che in noi, accanto all’energia della Vita, esiste anche la “consapevolezza di esistere”, l’impulso alla conoscenza donatoci dal Puruṣa inteso come potenziale testimone o spettatore dello spettacolo della Natura.
La manifestazione – “Natura naturata” – causata da Prakṛti – “Natura naturante”, non ha altro scopo se non quello di “esibirsi per il Puruṣa”.
La coscienza attivata dal Puruṣa non ha altro scopo se non quello di godere dello spettacolo della Natura attraverso gli organi di senso e di azione del corpo umano.
In tutto ciò noi non siamo altro che il “luogo di incontro” di Puruṣa e Prakṛti, il mediatore tra i due amanti divini che solo in noi, nel nostro corpo, hanno la possibilità di unirsi. Il corpo non è quindi, per lo Yoga, la “tomba dell’anima”, ma il talamo nuziale, sacro di per sé, nel quale la “dea” esibisce i suoi poteri creativi ed il “dio” può esercitare l’unico, infinito, potere possiede: il potere della coscienza.
Per molti praticanti occidentali di Yoga questi concetti potrebbero essere assai difficili da apprezzare: nella nostra cultura permeata dal dualismo Materia-Spirito, il corpo è stato (ed è) spesso considerato come la “Tomba dell’Anima”1, e tutto ciò che riguarda i processi mentali, dall’immaginazione alla capacità di astrazione, viene posto, quasi istintivamente, ad un livello più elevato rispetto al gesto o ai processi fisiologici, fino ad arrivare a considerare l’intera manifestazione come una creazione della mente, una specie di sogno dove ciò che definiamo realtà materiale non è “impermanente”, come affermano il buddhismo delle origini e il sāṃkhya, ma sostanzialmente “inesistente”.
Questo atteggiamento nichilista, noto, a dir la verità, sin dai tempi del Buddha storico, è lontano sia dalle concezioni dei primi haṭhayogin sia dagli insegnamenti di colui che viene definito “il padre dello Yoga [“meditativo”]”, Patañjali, che sembra considerare la realizzazione della “perfezione del corpo”, kāya-saṁpat, una conferma del successo nella pratica meditativa. Si legge nello Yoga Sūtra 3.45:
tataḥ aṇimā-ādi-prādurbhāvaḥ kāya-saṃpat tat-dharma-anabhighātaḥ ca ||3.45||
Ovvero:
Da questo (tatas) [ovvero dal fare saṁyama sugli aspetti grossolani, generali, sottili etc. degli elementi] insorgono (prādurbhāvaḥ) per primo (ādi) il potere di diventare piccoli come un atomo (aṇimā)2, [quindi] la perfezione del corpo (kāya sampad) e (ca) il non impedimento alle caratteristiche fondamentali (dharmanabhighātaḥ) [degli elementi].
La definizione di “perfezione del corpo” viene data nel versetto successivo, 3.46:
rūpa-lāvaṇya-bala-vajra-saṁhananatvāni kāya-saṁpat ||3.46||
Ovvero:
La perfezione del corpo (kāya sampad) [consiste] nella bellezza (rūpa), nella grazia (lāvaṇya), nella forza (bala) (e) nell’essere solidi come un diamante (vajra).
Concetto che sarà ribadito da Vyāsa, nel relativo commento :
[Il vero yogin è] bello da vedere, attraente, dotato di grande forza, con un corpo duro come il diamante.
Per ciò che riguarda la disciplina che Laura ed io pratichiamo e insegniamo da decenni, lo Haṭhayoga inteso come tecnica psico-fisica, sistematizzata nel medioevo dagli yogi della tradizione Nāth3, possiamo dire che si pone come obbiettivi:
- l’ottenimento della salute fisica e della bellezza;
- il ringiovanimento e la longevità;
- l’acquisizione di particolari poteri psichici definiti siddhi (सिद्धि);
- la realizzazione di una particolare condizione definita “stato naturale”, in sanscrito Sahaja siddhi (सहज सिद्धि) o semplicemente Sahaja (सहज).
Il corpo dello haṭḥayogin – grazie ad un addestramento basato sull’integrazione di posture, gesti, tecniche respiratorie e visualizzazioni – diviene, insieme, strumento ed oggetto di conoscenza. Grazie al lavoro sul corpo, “kāya sādhana”, si consegue la “realizzazione” intesa come trasmutazione della materia causata dall’attivazione e dall’utilizzazione di una energia denominata Kuṇḍalinī.
Come abbiamo già accennato, a differenza di altre tradizioni fondate sulla separazione di mente e corpo e sul predominio dello spirito sulla materia, lo Haṭhayoga si basa sul potere salvifico del corpo – o meglio, dell’insieme di corpo, parola e mente4 – in un’ottica ateistica e materialista che lo pone di fatto al di fuori dell’ortodossia brahmanica – intesa come sistema filosofico basato sull’autorità dei Veda – e, al contempo, ne evidenzia i legami con il buddhismo medioevale.
La centralità dei processi fisiologici e dei sensi, definiti da Gorakṣa “pañcadevatā (पञ्चदेवता)”5, il concetto di Kuṇḍalinī e il Sahaja visto come il fine ultimo dell’esistenza umana, sono temi che provengono, senza ombra di dubbio, dal Sahajāyāna, il buddhismo tantrico sviluppatosi a partire dal VI–VII secolo in Bengala, Assam e Odisha6.
Gli insegnamenti del Sahajāyāna erano basati sul «riconoscimento dell’identità di spirito e materia» e sulla consapevolezza che nella vita «non esiste [alcuna discriminazione tra] sacro o profano, spirituale o sensuale, ma tutto ciò che vive è puro e vuoto»7.
Nel Sahajāyāna si afferma il primato della esperienza sensoriale, da cui deriva l’importanza, fondamentale, attribuita al desiderio e al godimento sessuale. La pratica dei sahaja yogi è finalizzata allo scioglimento dei blocchi, fisici, mentali e morali, che impediscono la libera espressione delle energie vitali. Una volta sciolti i blocchi lo yogi ha la possibilità di sperimentare – e utilizzare – quattro tipi di piacere:
Il primo piacere viene dal desiderio di contatto, il secondo dal desiderio di beatitudine, il terzo dalla fine delle passioni. In questo modo si realizza il quarto piacere [Sahaja]. Il piacere perfetto dell’unione è il Saṃsāra. Il piacere della cessazione è il Nirvana. Nel sahaja non c’è desiderio né assenza di desiderio.8
Questo insistere sul tema del piacere, anziché sulla mortificazione del corpo , insieme all’esistenza di pratiche sessuali ritualizzate, sia di coppia sia di gruppo, descritte, in maniera quasi identica, nei testi del buddhismo tibetano e nei primi manuali di Haṭhayoga9, ci svela un piccolo grande segreto: lo Yoga “del corpo”, basato sul primato dell’esperienza, è ciò che, un tempo veniva definito “Tantra”.
Per tornare alla questione iniziale, la pratica dello Yoga, a pensarci bene, ci ha portato alla consapevolezza che il corpo non è “nostro”, ma è un qualcosa che appartiene alla Natura (Prakṛti, la dea o comunque la si voglia chiamare): è lei che, per pura generosità, ci mette a disposizioni i sensi, la carne, la mente per permetterci di godere della vita e, allo stesso tempo, di essere coscienti del godimento. Il corpo, quindi, non è solo la rappresentazione plastica della manifestazione, ma è anche lo strumento o, meglio, l’insieme degli strumenti che permettono di vivere la Vita. È da qui, da questa consapevolezza che nasce la necessità di curare e rispettare il corpo: se il nostro mestiere è quello di vivere che altro potremmo fare se non mantenere puliti ed efficienti gli attrezzi del mestiere?
Il corpo è il teatro, i sensi sono gli spettatori, Śiva è il danzatore.
BIBLIOGRAFIA
1 Dicono alcuni che il corpo è séma (segno, tomba) dell’anima, quasi che ella vi sia sepolta durante la vita presente”. [Platone (Cratilo) in “Platone, Opere, vol. I”, Laterza, Bari, 1967, pagg. 213-214]
2 Aṇimā – il potere di diventare piccoli come un atomo – è la prima (ādi) a manifestarsi tra le otto realizzazioni o poteri siddhi (<सिद्धि) dello Yoga; vedi ad esempio:
- Brahmāṇḍa-purāṇa I. 2. 39; II. 29.82; III. 3.65; 36.17; 67.16;
- Vāyu-purana 2.39; 13.3; 57.76; 92.15.
Esistono diversi elenchi delle otto siddhi, ma per ciò che riguarda il sūtra 3.45 dello Yoga Su<̄<tra, in genere ci si attiene al seguente elenco:
- Animā: capacità di diventare piccolo come un atomo
- Mahimā: capacità di diventare enorme;
- Laghimā: capacità di diventare molto leggero;
- Garimā: capacità di diventare molto pesante;
- Prāpti: capacità di realizzare qualsiasi cosa;
- Prakāmya : capacità di andare ovunque;
- Īśita: capacità di controllare gli elementi e le forze della natura;
- Vaśita: capacità di esercitare un’influenza su chiunque.
3< Vedi <Constance Jones; James D. Ryan (2006). <Encyclopedia of Hinduism<. Infobase Publishing. <ISBN< <978-0-8160-7564-5<:
Nath o Natha , è una sottotradizione Shaiva […]sviluppatasi in India e Nepal nel medioevo […] che univa le idee del Buddismo, dello Shaivismo e delle tradizioni Yoga in India<.
4< Per lo <haṭḥayoga<, come vedremo in seguito, anche i pensieri e le emozioni fanno parte della sfera “materiale”, sono, in altre parole, “sostanza”.
5 “Cinque divinità (protettrici)”; vedi Gorakṣa Saṃhitā versetto 1.13:
ekastambhaṃ navadvāraṃ gṛhaṃ pañcādhidaivatam /
svadehe ye na jānanti kathaṃ siddhyanti yoginaḥ //13//
6 Vedi: Ramprasad Mishra, “Sahajayana” (A Study of Tantric Buddhism), preface.
7 Vedi: Ananda Kentish Coomaraswamy; “The dance of Śiva: essays on Indian art and culture”. Edition: reprint, illustrated. Courier Dover Publications. 1985). ISBN 0-486-24817-8, ISBN 978-0-486-24817-2.
8 Vedi: John Noice, “The Origin of Sahaja”
9 Vedi il nostro “Tantra, la Via del Sesso”